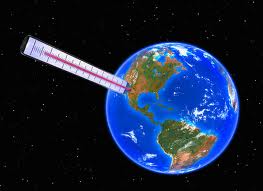Ma l’alternativa a Marchionne c’è

Pubblichiamo
con molto piacere un articolo di Guido Viale tratto dal quotidiano
“Il Manifesto” del 16 giugno 2010. Guido Viale è stato
recentemente nostro ospite come relatore all’incontro“Smog
on the road”sul tema del trasporto pubblico.
Non
c’è alternativa. Questa sentenza apodittica di Margaret Thatcher per
la quale è stato creato anche un acronimo (Tina: there is no
alternative) è la silloge del cosiddetto «pensiero unico» che nel
corso dell’ultimo trentennio ha accompagnato le dottrine più o meno
«scientifiche» da cui sono state orientate, o con cui sono state
giustificate, le scelte di volta in volta dettate dai detentori del
potere economico: prima liberismo (a parole, con grande dispendio di
diagrammi e formule matematiche, ma senza mai rinunciare agli aiuti
di stato e alle pratiche monopolistiche); poi dirigismo e capitalismo
di stato (per salvare banche, assicurazione e giganti dell’industria
dai piedi d’argilla dal precipizio della crisi); per passare ora a un
vero e proprio saccheggio, usando come fossero bancomat salari,
pensioni, servizi sociali e «beni comuni», per saldare i debiti
degli Stati messi in crisi dalle banche appena salvate. Così la
ricetta che non contempla alternative oggi è libertà dell’impresa;
che va messa al di sopra di sicurezza, libertà e dignità,
ovviamente dei lavoratori, inopportunamente tutelate dall’art. 41
della Costituzione italiana.
A
enunciarlo in forma programmatica è stato Berlusconi, subito ripreso
dal ministro Tremonti e, a seguire, dall’autorità sulla concorrenza,
che non ha mai mosso dito contro un monopolio. A tradurre in pratica
quella ricetta attraverso un aut aut senza condizioni, subito
salutato dagli applausi degli imprenditori giovani e meno giovani di
Santa Margherita Ligure, è stato l’amministratore delegato della
Fiat, il Valletta redivivo del nuovo secolo. Eccola. Limitazione
drastica (e anticostituzionale, ma per questi signori la Costituzione
va azzerata; e in fretta!) del diritto di sciopero e di quello di
ammalarsi.
Una
organizzazione del lavoro che sostituisce l’esattezza cronometrica
del computer alla scienza approssimativa dei cronometristi (quelli
che un tempo alla Fiat si chiamavano i «vaselina», perché si
nascondevano dietro le colonne per spiare gli operai e tagliargli
subito i tempi se solo acceleravano un poco per ricavarsi una piccola
pausa per respirare). Una turnazione che azzera la vita familiare,
subito sottoscritta da quei sindacalisti e ministri che due anni fa
erano scesi in piazza per «difendere la famiglia»: la loro, o le
loro, ovviamente. È un ricatto; ma non c’è alternativa. Gli operai
non lo possono rifiutare e non lo rifiuteranno, anche se la Fiom,
giustamente, non lo sottoscrive. L’alternativa è il licenziamento
dei cinquemila dell’Alfasud – il «piano B» di Marchionne – e di
altri diecimila lavoratori dell’indotto, in un territorio in cui
l’unica vera alternativa al lavoro che non c’è è l’affiliazione
alla camorra.
Per
anni, a ripeterci «non c’è alternativa» sono stati banchieri
centrali, politici di destra e sinistra, sindacalisti
paragovernativi, professori universitari e soprattutto bancarottieri.
Adesso, forse per la prima volta, a confermarlo con un referendum,
sono chiamati i lavoratori stessi che di questo sopruso sono le
vittime designate. Ecco la democrazia del pensiero unico: votate
pure, tanto non c’è niente da scegliere.
Effettivamente,
al piano Marchionne non c’è alternativa. Nessuno ci ha pensato;
neanche quando il piano non era ancora stato reso pubblico. Nessuno
ha lavorato per prepararla, anche quando la crisi dell’auto l’aveva
ormai resa impellente. Nessuno ha mai pensato che sarebbe stato
necessario averne una, anche se era chiaro da anni che prima o poi –
più prima che poi – la campana sarebbe suonata: non solo per Termini
Imerese, ma anche per Pomigliano.
Ma
a che cosa non c’è alternativa? Al «piano A» di Marchionne. Un
piano a cui solo se si è in malafede o dementi si può dar credito.
Prevede che nel giro di quattro anni Fiat e Chrysler producano – e
vendano – sei milioni di auto all’anno: 2,2 Chrysler, 3,8 Fiat, Alfa
e Lancia: un raddoppio della produzione. In Italia, 1,4 milioni: più
del doppio di oggi. La metà da esportare in Europa: in un mercato
che già prima della crisi aveva un eccesso di capacità del 30-35
per cento; che dopo la sbornia degli incentivi alla rottamazione, è
già crollato del 15 per cento (ma quello della Fiat del 30); e che
si avvia verso un periodo di lunga e intensa deflazione.
Quello
che Marchionne esige dagli operai, con il loro consenso, lo vuole
subito. Ma quello che promette, al governo, ai sindacati,
all’«opinione pubblica» e al paese, è invece subordinato alla
«ripresa» del mercato, cioè alla condizione che in Europa tornino
a vendersi sedici milioni di auto all’anno. Come dire: «il piano A»
non si farà mai.
Non
è una novità. Negli ultimi dieci anni, per non risalire più
indietro nel tempo, di piani industriali la Fiat ne ha già sfornati
sette; ogni volta indicando il numero di modelli, di veicoli,
l’entità degli investimenti e la riduzione di manodopera previsti.
Tranne l’ultimo punto, che era la vera posta in palio, degli
obiettivi indicati non ne ha realizzato, ma neanche perseguito,
nemmeno uno. Ma è un andazzo generale: se i programmi di rilancio
enunciati da tutte le case automobilistiche europee andassero in
porto (non è solo la Fiat a voler crescere come un ranocchio per non
scomparire) nel giro di un quinquennio si dovrebbero produrre e
vendere in Europa 30 milioni di auto all’anno: il doppio delle
vendite pre-crisi. Un’autentica follia.
Dunque
il «piano A» non è un piano e non si farà. L’alternativa in
realtà c’è, ed è il «piano B». Se a chiudere non sarà
Pomigliano, perché Marchionne riuscirà a farsi finanziare da banche
e governo (che agli «errori» delle banche può sempre porre
rimedio: con il denaro dei contribuenti) i 700 milioni di
investimenti ipotizzati e a far funzionare l’impianto – cosa
tutt’altro che scontata – a cadere sarà qualche altro stabilimento
italiano: Cassino o Mirafiori. O, più probabilmente, tutti e tre. La
spiegazione è già pronta: il mercato europeo non «tirerà» come
si era previsto
Hai
voglia! Il mercato europeo dell’auto è in irreversibile contrazione;
l’auto è un prodotto obsoleto che nei paesi ad alta intensità
automobilistica non può che perdere colpi: «tirano», per ora, solo
i paesi emergenti – fino a che il disastro ambientale, peraltro
imminente, non li farà recedere anch’essi – ma le vetture che si
vendono là non sono certo quelle che si producono qui: né in Italia
né in Polonia.
Anche
se la cosa non inciderà sulle scelte dei prossimi mesi, è ora di
dimostrare che non è vero che non c’è alternativa. L’alternativa è
la conversione ambientale del sistema produttivo – e dei nostri
consumi – a partire dagli stabilimenti in crisi e dalle fabbriche di
prodotti obsoleti o nocivi, tra i quali l’automobile occupa il
secondo posto, dopo gli armamenti. I settori in cui progettare,
creare opportunità e investire non mancano: dalle fonti di energia
rinnovabili all’efficienza energetica, dalla mobilità sostenibile
all’agricoltura a chimica e chilometri zero, dal riassetto del
territorio all’edilizia ecologica. Tutti settori che hanno un futuro
certo, perché il petrolio costerà sempre più caro – e persino le
emissioni a un certo punto verranno tassate – mentre le fonti
rinnovabili costeranno sempre meno e l’inevitabile perdita di potenza
di questa transizione dovrà essere compensata dall’efficienza
nell’uso dell’energia. L’industria meccanica – come quella degli
armamenti – può essere facilmente convertita alla produzione di pale
e turbine eoliche e marine, di pannelli solari, di impianti di
cogenerazione. Poi ci sono autobus, treni, tram e veicoli condivisi
con cui sostituire le troppe auto, assetti idrogeologici da salvare
invece di costruire nuove strade, case e città da riedificare –
densificando l’abitato – dalle fondamenta.
Ma
chi finanzierà tutto ciò? Se solo alle fonti rinnovabili fosse
stato destinato il miliardo di euro che il governo italiano (peraltro
uno dei più parsimoniosi in proposito) ha gettato nel pozzo senza
fondo delle rottamazioni, ci saremmo probabilmente risparmiati i due
o tre miliardi di penali che l’Italia dovrà pagare per aver mancato
gli obiettivi di Kyoto. Ma anche senza incentivi, le fonti
rinnovabili si sosterranno presto da sole e i flussi finanziari oggi
instradati a cementare il suolo, a rendere irrespirabile l’aria delle
città, impraticabili le strade e le piazze, a riempirci di veleni
per rendere sempre più sterili i suoli agricoli, a sostenere
un’industria delle costruzioni che vive di olimpiadi, expo, G8, ponti
fasulli e montagne sventrate potranno utilmente essere indirizzati in
altre direzioni. È ora di metterci tutti a fare i conti!
Ma
chi potrà fare tutte queste cose? Non certo il governo. Né questo
né – eventualmente – uno di quelli che abbiamo conosciuto in
passato; e meno che mai la casta politica di qualsiasi parte.
Continuano a riempirsi la bocca con la parola crescita e stanno
riportandoci all’età della pietra. La conversione ecologica si
costruisce dal basso «sul territorio»: fabbrica per fabbrica, campo
per campo, quartiere per quartiere, città per città. Chi ha detto
che la programmazione debba essere appannaggio di un organismo
statuale centralizzato e non il prodotto di mille iniziative dal
basso? Chiamando per cominciare a confrontarsi in un rinnovato
«spazio pubblico», senza settarismi e preclusioni, tutti coloro che
nell’attuale situazione non hanno avvenire: gli operai delle
fabbriche in crisi, i giovani senza lavoro, i comitati di cittadini
in lotta contro gli scempi ambientali, le organizzazioni di chi sta
già provando a imboccare strade alternative: dai gruppi di acquisto
ai distretti di economia solidali. E poi brandelli di amministrazioni
locali, di organizzazioni sindacali, di associazioni professionali e
culturali, di imprenditoria ormai ridotta alla canna del gas (non ci
sono solo i «giovani imprenditori» di Santa Margherita); e nuove
leve disposte a intraprendere, e a confrontarsi con il mercato, in
una prospettiva sociale e non solo di rapina.
Il
tessuto sociale di oggi non è fatto di plebi ignoranti, ma è saturo
di intelligenza, di competenze, di interessi, di saperi formali e
informali, di inventiva che l’attuale sistema economico non sa e non
vuole mettere a frutto.
Certo,
all’inizio si può solo discutere e cominciare a progettare. Gli
strumenti operativi, i capitali, l’organizzazione sono in mano di
altri. Ma se non si comincia a dire, e a saper dire, che cosa si
vuole, e in che modo e con chi si intende procedere, chi promuoverà
mai le riconversioni produttive?